Una breve analisi sul potere finanziario e gli investimenti internazionali compiuti dalla Cina nei paesi più poveri del mondo e i rapporti con il nostro Paese nel quale la leadership delle acquisizioni straniere, però, spetta sempre agli Stati Uniti.
Quando lo scorso marzo il presidente cinese Xi Jinping atterrò a Palermo fui colto da una visione grottesca simile ai deliri che mettevano in scena Enzo Maresco e Daniele Ciprì nel loro Cinico Tv. Nella fattispecie, lo sketch al quale mi riferisco è quello che vede il sig. Tirone (il ciclista) interrogarsi sulla possibilità che Berlusconi potesse acquistare la Sicilia. I dubbi di Tirone, però, sono gli stessi che oggi attanagliano il sottoscritto, perchè se è vero che Silvio – di fatto – non comprò mai la Trinacria (non ufficialmente, almeno) è anche vero che, stavolta, qualcuno potrebbe farlo seriamente, allargando il suo potere d’acquisto anche oltre lo Stretto di Messina: la Cina.

Da quasi un decennio, infatti, la potenza guidata (sine die) da Xi Jinping sta conducendo una vera e propria politica di espansione colonialista mondiale, trovando terreno fertile soprattutto nei paesi economicamente più poveri adottando un sistema molto simile a quello adottato dagli usurai: io – Cina – ti presto il denaro necessario alla realizzazione di un’opera X, tu – paese con debito pubblico superiore al 180 per cento – mi rendi la cifra che ti ho prestato a tassi altissimi e in un determinato arco di tempo e qualora non riuscissi a saldare tale debito saresti costretto a cedermi l’opera che ti ho costruito. Semplicissimo.

La campagna d’Africa.
Innanzitutto, uno dei pregi che bisogna riconoscere alla Cina è quello di essersi sostituita agli alleati e sostenitori economici storici degli stati africani e della regione indocinese – Regno Unito e Francia su tutti – che negli ultimi anni hanno abbandonato al loro destino le loro ex colonie, tagliando sovvenzioni e limitando gli investimenti. I cinesi, dal canto loro, hanno compreso il disagio di questi paesi e sono riusciti ad insinuarsi benissimo nel loro tessuto socio-economico intraprendendo delle strategie concrete. Se i paesi occidentali hanno sempre proposto dei piani di investimento che potessero contribuire allo sviluppo e alla cooperazione anche tra i paesi della stessa area (azioni giuste che però avrebbero comportato lungaggini burocratiche, controlli fiscali e, soprattutto, lunghissimi tempi di realizzazione), i cinesi, invece, oltre a essersi presentati con soluzioni reali (capitali) e immediate, dotando questi paesi di infrastrutture e compiendo opere di bonifica sulle aree destinate alle colture, riscuotendo il consenso dei governanti locali che, all’ultimo Forum sulla Cooperazione Cina-Africa, ne hanno tessuto pubblicamente le lodi (lisciata di pelo dovuta, essenzialmente, al nuovo piano di investimenti di circa 60 miliardi promosso dai cinesi e che dovrebbe consolidarsi nei prossimi 2 anni).

Alle porte d’Europa.
Dopo aver conquistato l’Africa, il governo di Pechino aveva la necessità di conquistare un ulteriore avamposto nello scacchiere geopolitico ed economico mondiale, anche nell’ottica della guerra fredda con gli Stati Uniti di Donald Trump. Quel punto strategico tanto bramato da Xi Jinping era il porto del Pireo ad Atene, scalo mercantile di importanza strategica fondamentale che – di fatto – è diventato la porta d’ingresso cinese all’Europa.
Lo scorso 11 novembre, infatti, il presidente greco Kyriakos Mītsotakīs e Xi Jinping hanno siglato un protocollo di 16 punti che prevede delle concessioni e dei benefici reciproci relativamente ai rapporti tra i paesi. Il problema, però, risiede in una questione: il peso specifico dei vantaggi di entrambi gli stati che cercherò di spiegarvi in due parole: la Grecia potrà godere di tassi doganali agevolati per le esportazioni dei propri prodotti del settore agroalimentare in Oriente, la Cina controllerà ufficialmente il porto del Pireo (che aveva già precedentemente costruito) e provvederà ad espanderlo costruendo un porto per l’attracco di navi da crociera, un hotel e un terminal per container da 600 milioni.
In altre parole, la Grecia potrà esportare feta e olive senza troppi problemi, la Cina, oltre a controllare i traffici in entrata e in uscita dall’est Europa, sarà il primo paese a far fruttare i propri profitti in un paese europeo ma in banche cinesi (a breve, ad Atene, è prevista l’apertura di una filiale di Bank of China e della Commercial Bank of China, l’istituto bancario più potente al mondo).
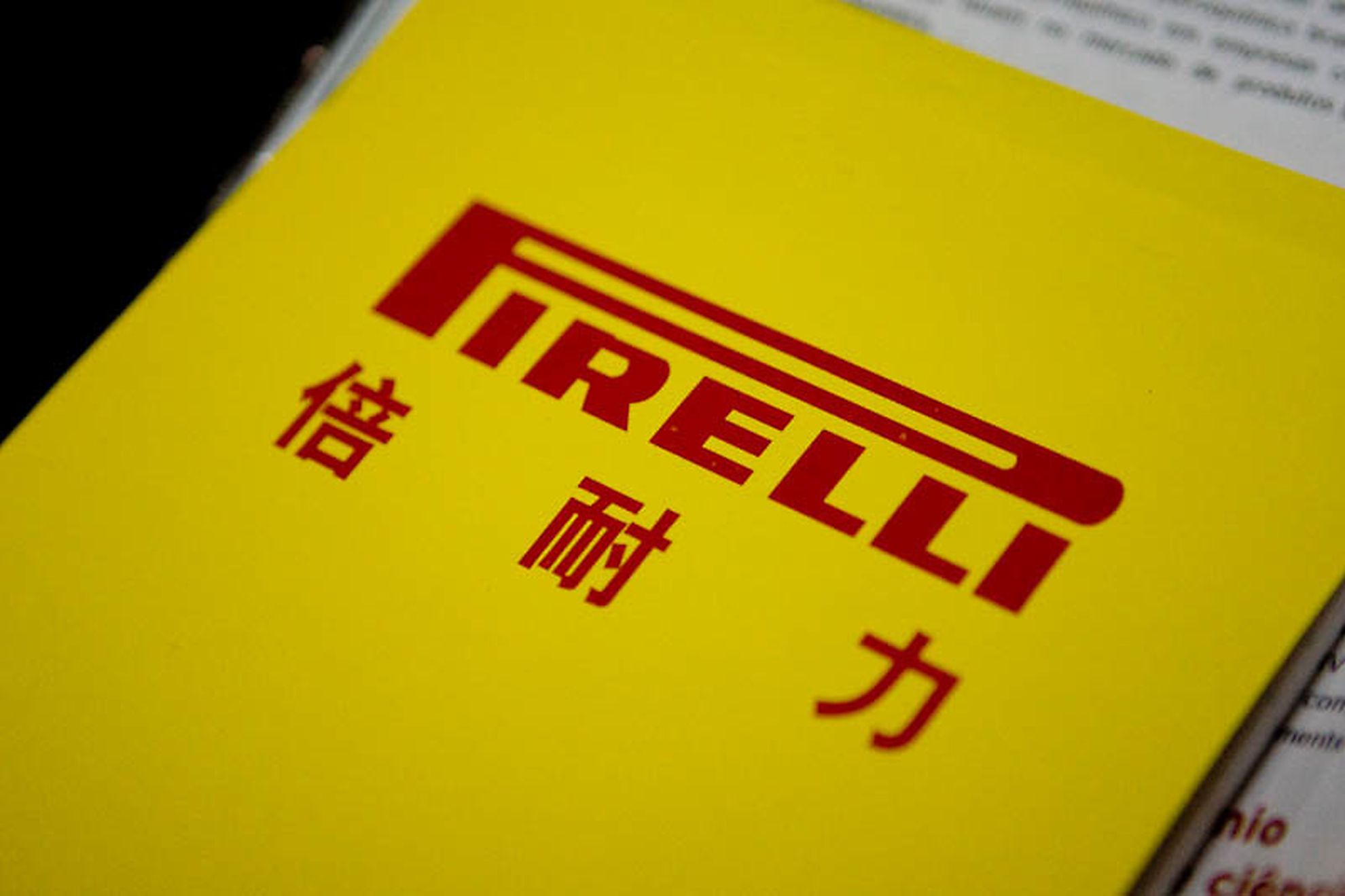
In Italia.
La visita di marzo del presidente cinese ha ridefinito i principi dei rapporti commerciali tra Italia e Cina per quella che, simbolicamente, è stata battezzata Via della Seta.
A differenza degli altri paesi (decisamente più poveri del nostro), i cinesi in Italia si sono sempre mossi con cautela perchè realmente attratti da due cose: i grandi marchi e le eccellenze industriali. Dall’acquisizione della maison di Valentino e altri brand di lusso come Caruso e Buccellati, alla partecipazione societaria in Pirelli da 7,2 miliardi di euro, passando per il controllo di quote in altre realtà industriali come Ansaldo Energia, Cdp Rieti, senza dimenticare gli acquisti dell’Inter e del Milan (prima che il club rossonero tornasse al fondo Elliott).

Recentemente, pare che gli investitori stiano guardando alla pura tecnologia di nicchia sviluppata da aziende più piccole per scopi legati alla strategia più che al profitto. In questo senso, l’obiettivo degli investitori cinesi sarebbe quello di finanziare le startup che nascono dal genio dei nostri ingegneri badando unicamente ad assimilare e adottare “come si fa”.
Se, da un lato, questi investimenti hanno prodotto degli effetti positivi permettendo l’ingresso di capitali che hanno dato una mossa allo stallo finanziario in cui versa attualmente la nostra economia, risolvendo anche qualche problema ai nostri imprenditori, dall’altro ne hanno prodotto un altro da non trascurare, ovvero il trasferimento del know-how ai cinesi e i conseguenti contrasti (anche culturali) tra la forza lavoro (in questo caso italiana) e il management cinese. Per ovviare a questo problema, i due paesi hanno stilato un regolamento congiunto che determina i rapporti e la cooperazione su un principio di reciprocità, considerato anche il fatto che gli investimenti in entrata in Cina non possono avere luogo in assenza di partner cinesi. In altre parole, condizioni ben più vantaggiose rispetto alla facoltà concessa alla Grecia di vendere formaggio o olive sul mercato asiatico.

Le soluzioni.
È comunque improbabile che un tema così delicato possa essere risolto esclusivamente a livello italiano. Il rischio di appropriazione della proprietà intellettuale e delle tecnologie nazionali da parte di investitori stranieri è comune a molti Paesi, per questo sarebbe opportuno che organi sovranazionali come l’UE studiassero dei meccanismi in grado di salvaguardare la sicurezza, l’ordine pubblico e gli interessi strategici dell’Europa. Lo stesso Jean-Claude Juncker (promotore del Framework europeo per lo screening degli investimenti stranieri), già qualche anno fa, aveva affermato che l’Europa avesse la necessità di controllare concretamente gli acquisti delle società straniere che avessero come unico obiettivo l’acquisizione delle attività strategiche dell’Europa.
In definitiva, per rispondere alla ipotetica domanda del Sig. Tirone, sì: l’Italia è in vendita ma non solo alla Cina (che a livello europeo è il terzo paese scelto dai cinesi per volume di investimenti compiuti, i primi sono Regno Unito e Francia). Gli Stati Uniti rimangono sempre i primi acquirenti di società italiane, con oltre 15 miliardi di dollari investiti negli ultimi tre anni anche se a fare scalpore restano unicamente gli investimenti dei cinesi, senza dimenticare che – recentemente – qualche genio ha cercato l’appoggio finanziario anche da paesi meno mediatici ma che di certo non stanno a guardare. Ci sono una moltitudine di attori internazionali attratti dal patrimonio aziendale italiano e disposti ad investire capitali. Per preservare le economie dei paesi più deboli, la regolamentazione a livello comunitario può fare davvero la differenza, soprattutto per la definizione dei canoni di quelle che – sulla carta – vengono dipinte come cooperazioni transnazionali ma che in realtà possono diventare a tutti gli effetti delle vere e proprie svendite fallimentari.

